Indubbiamente, quello che ci appare nel racconto è un Gesù umano, compassionevole e misericordioso verso...
Unione sovietica: la grande dissoluzione
L'Urss si sciolse ufficialmente il 26 dicembre 1991. Era composta da quindici Repubbliche socialiste, la più grande delle quali era la Russia. Poi, un trentennio di guerre e tensioni. Fino all’odierno conflitto in Ucraina
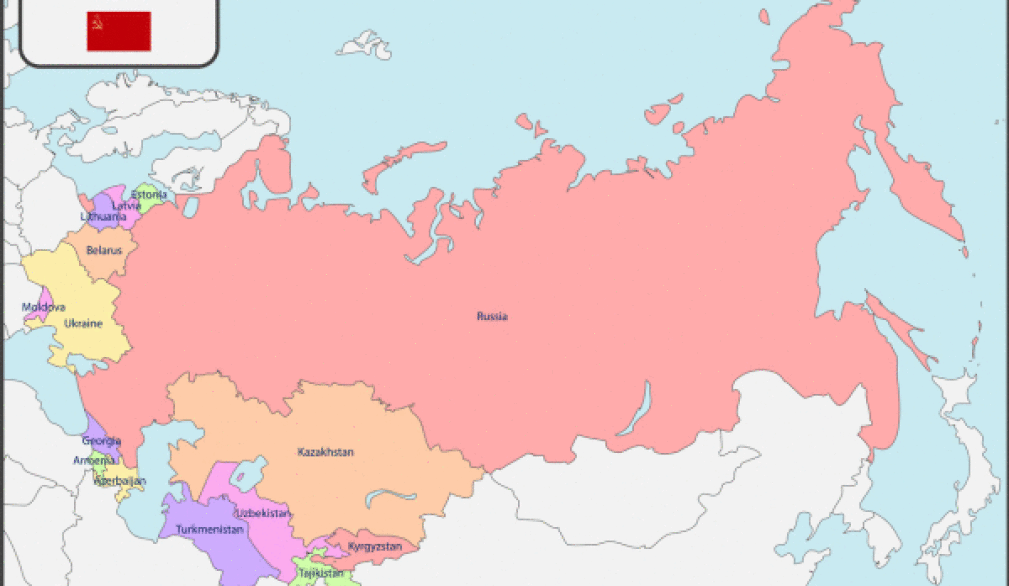
Da anni, nell’est dell’Ucraina, si combatte un conflitto, nel cuore dell’Europa. In queste settimane la situazione è degenerata sino alla drammatica invasione delle truppe di Mosca del territorio ucraino. Quanto sta accadendo parte da lontano e attraversa tutto il Novecento. Corsi e ricorsi della storia hanno portato il conflitto proprio in Ucraina, come un secolo fa, durante la guerra civile.
Il trattato di collaborazione
Quando l’Ucraina votò per l’indipendenza dall’Unione Sovietica (Urss), nel dicembre del 1991, era chiaro a tutti che l’impero comunista fosse ormai giunto al suo capolinea.
Una settimana dopo, l’8 dicembre, i presidenti delle Repubbliche sovietiche di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono il trattato istitutivo della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) a Brest, dando di fatto inizio al processo di disgregazione dell’Urss.
Alla nuova alleanza si unirono ben presto tutti gli ex-Stati membri dell’Unione Sovietica, ad eccezione delle Repubbliche baltiche, Estonia, Lettonia e Lituania, che da sempre avevano considerato Mosca alla stregua di una potenza occupante. A oggi, la Comunità degli Stati indipendenti conta nove membri: Russia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan e Uzbekistan.
Guardando indietro: nascita e morte dell’Urss
L’Unione Sovietica era nata il 30 dicembre 1922 come Stato federale, che si estendeva tra l’Europa orientale - dai Carpazi agli Urali - e l’Asia settentrionale, sulle ceneri dell’Impero russo, dopo la Rivoluzione d’ottobre (1917).
Si sciolse ufficialmente il 26 dicembre 1991, due anni dopo la caduta del muro di Berlino. Era composta da 15 Repubbliche socialiste, la più grande delle quali era la Russia. Le altre Repubbliche: 6 (le attuali Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Ucraina) dislocate in Europa e 8 (le attuali Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) in Asia. Tre quarti dei suoi abitanti vivevano in Europa, su un quarto della sua estensione totale.
Una Unione “zoppa”
L’idea degli Stati fondatori della Csi era quella di dare vita a una nuova “Unione russa”, basata però su un diverso rapporto tra Mosca e le altre capitali.
Cercando di condividere le scelte in campo di politica estera, economica e militare, la Russia voleva evitare che anche i vicini più stretti cadessero sotto l’influenza dell’Unione europea e della Nato, come avvenne con gli Stati dell’Europa orientale. Di tutti gli Stati membri, otto partecipano all’area di libero scambio. Esistono poi altre forme strutturate di collaborazione in campo politico-economica oltreché militare, pensate sulla falsariga degli accordi della vicina Unione europea.
Con il passare del tempo, la partecipazione selettiva degli Stati membri ad alcuni trattati, invece che ad altri, è diventata un’abitudine.
Ciò ha portato a ridurre il peso della Csi su base regionale e a creare delle divisioni tra gli stessi Stati ex-sovietici.
Nel corso degli anni, Georgia e Ucraina hanno infatti ritirato la loro partecipazione alla Comunità, a causa dei conflitti militari scoppiati con la Russia rispettivamente nel 2008 e nel 2014.
Trent’anni di guerre
Nei tre decenni trascorsi dalla scomparsa dell’Impero sovietico, di sanguinosi conflitti ce ne sono stati tanti. Ecco quali sono state le guerre condotte da Mosca nei territori confinanti.
Nel decennio in cui il presidente è stato Boris Eltsin, le truppe russe hanno combattuto: in Georgia, nel ’91-’93; in Moldavia, nel ’92 (qui si consolidò la Repubblica di Transnistria, un eclave russofono, confinante con l’Ucraina, tuttora fedele alla Russia e separato dal resto della piccola Nazione), in Inguscezia (una regione russa ai confini del Caucaso) sempre nel ’92; in Tagikistan, nel ’92-’97; infine, nel ’99, nella regione autonoma separatista del Daghestan.
Da ricordare, poi, la prima guerra di Cecenia nel ’94-’96 (al termine della quale la piccola repubblica caucasica ottenne l’indipendenza da Mosca), perché con l’avvento di Putin, nell’autunno del 1999, essa divenne teatro di un secondo intervento armato russo, portando la Cecenia a essere un “fantoccio” alle dipendenze del Cremlino, nell’ambito della Federazione russa.
Grazie alla collaborazione russa di peacekeeping in Kosovo con la Nato, il presidente Vladimir Putin si accreditò via via tra le Cancellerie occidentali, tanto stabilmente che il vertice dei G7, il gruppo dei Paesi più industrializzati del mondo di cui fa parte anche l’Italia, si allargò alla Russia diventando G8 fino al 2014, quando venne occupata la Crimea.
Nel frattempo, Putin ha continuato a fare la guerra in altri scenari ex-sovietici. Nel 2008 in Georgia, e in particolare nelle regioni russofone di Abkhazia e Ossezia del Sud; poi, come detto, nel 2014 in Crimea e nella regione del Donbass.
Insurrezioni in varie regioni del Caucaso settentrionale, tra il 2009 e il 2017, hanno provocato l’intervento delle forze russe: non solo in Cecenia, ma anche in altre Repubbliche della Federazione russa: Daghestan, Inguscezia, Kabardino-Balkaria e Ossezia del Nord.
Inoltre, Putin ha inviato l’anno scorso truppe in Bielorussia per aiutare il regime autoritario locale a reprimere vaste rivolte popolari, così rimettendo sotto il controllo di Mosca anche questa vasta ex Repubblica sovietica.
Gli eventi recenti
Il penultimo intervento militare russo, prima dell’aggressione all’Ucraina, risale solo a due mesi fa, quando con tutta probabilità i piani per l’invasione dell’Ucraina erano già in fase avanzata, e ha riguardato un’altra enorme Repubblica ex sovietica, il Kazakistan.
In occasione della votazione all’Assemblea generale dell’Onu dello scorso 2 marzo, delle originarie 15 Repubbliche socialiste, hanno votato a favore della condanna dell’invasione russa solo Georgia e Moldavia, oltre all’Ucraina. La Bielorussia ha votato contro, le altre Nazioni, tutte situate nel Continente asiatico, si sono astenute.
Nel frattempo la Russia era entrata in guerra anche in altri Paesi: Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali.











